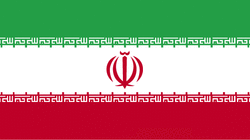Il grande abbraccio russo Si è concluso all’ombra del Cremlino l’ultimo colpo dei russi nel campo degli investimenti energetici. Rosneft, questo il nome della compagnia statale petrolifera russa che compra in questi giorni il 100 % della Tnk-Bp, joint venture ( una specie di collaborazione tra aziende) anglo-russa. E’ una delle brillanti idee di Vladimir Putin, che consolida così al fianco del colosso del gas Gazprom, un altro gigante energetico, primo al mondo. Infatti Rosneft dopo questa acquisizione supera l’americana Exxon toccando quota 4,5 milioni di barili di petrolio come produzione giornaliera. Acuta visione quindi quella dello stratega moscovita, che rafforza l’autonomia energetica e tira fuori da molti problemi la Bp, compagnia inglese dell’oro nero nota per il disastro di due anni fa nel Golfo del Messico. E non lo fa per solidarietà o simpatia nei confronti dei britannici. Grazie a Gazprom , azienda pubblica come Rosneft, che controlla la metà del gas che scorre sotto i terreni d’Europa, compresi quelli italiani, Putin regala a sé e alla Russia un potere strategico sul Vecchio Continente non indifferente, questo è il motivo principale dei grandi movimenti finanziari che le compagnie pubbliche russe stanno attuando, certo non perché non dormirebbero la notte sapendoci al freddo. Il suo è un disegno più ampio, che lega strettamente l’economia nazionale alla politica estera. La Russia è affacciata per una parte sull’Europa, per l’altra, molto maggiore, sull’intera Asia.
 Con l’Unione Europea i rapporti sono buoni, con qualche screzio per via del sostegno russo al regime bielorusso, conosciuto come l’ultima dittatura d’Europa. Le relazioni economiche sono intensissime, e non potrebbe essere altrimenti, sia in materia energetica, che di scambi commerciali. Le aziende russe hanno un grosso vantaggio a lavorare in Europa, si ritrovano praticamente sotto casa il più grande mercato libero del mondo, investimenti a più non posso quindi. Ma prima di tutto la Russia è legata all’Europa per il gas, è qui che svolge la parte del leone, ma è sempre in questo caso che ha dei competitors. Primo fra tutti l’Algeria, la quale con i suoi gasdotti che attraversano il Mediterraneo minaccia il monopolio di Mosca. Soprattutto perché la maggior parte dei paesi europei che affacciano sul Mare Nostrum hanno accordi commerciali con entrambi, Francia e Italia in primis, poiché non possono rischiare una mancanza di approvvigionamento energetico, rifornirsi sia da Algeri che da Mosca da più garanzie. Dal lato del petrolio, ora Rosneft si sostituisce a Gazprom. La nuova compagnia statale è leader mondiale nel campo, si avvantaggia quindi sull’unico altro produttore di greggio nel mediterraneo, la Libia. Questo è uno dei motivi per i quali i russi erano restii all’intervento congiunto delle forze occidentali in territorio libico nella primavera del 2011. Ciò avrebbe fornito un accesso diretto alle risorse energetiche di aziende francesi, italiane e inglesi, che infatti vi si sono gettate a capofitto.
Paragonata con le questioni che la Russia deve dirimere in Asia, il controllo della gestione energetica in Europa è un gioco da ragazzi, facile come incastrare matriosche. Quando l’ex potenza sovietica ragiona sull’Asia, riflette su un continente intero, non Medio o Vicino Oriente, non regione Caucasica, non India o Cina. Tutto, i suoi interessi spaziano dalla Mongolia al Bahrain, dal Giappone alla Siria. Con quest’ultima si concentrano i problemi più recenti. Oramai si sa che Mosca non molla il regime di Assad perché è sulle coste siriane che ha a disposizione l’unica base militare nel mediterraneo. Dal punto di vista energetico, oltre che politico, la Russia ha un pieno controllo sulla regione caucasica. I gasdotti attraversano il mar Caspio da nord a sud, spingendosi fino in Iran. Paese rivale in materia di politica energetica, perché a Teheran manca il gas, ma non il petrolio. Questi legami energetici cingono tutta l’Asia centrale, dal desolato Kazakistan all’Afghanistan e poi più a sud. Sono soprattutto questi legami a rendere la Russia molto diplomatica, cauta con le sanzioni all’Iran, restia a invasioni o violazioni di sovranità nei paesi suoi partners commerciali. Il cartello dei paesi produttori di petrolio, l’OPEC, non comprende l’ex potenza sovietica, che ne resta fuori, avendo le mani libere. Quello della Russia non è un progetto di potenza, ma principalmente di sopravvivenza. E’ finito il tempo del gigante URSS che dipendeva in tutto e per tutto dal grano americano, ora a Mosca cercano di fare da soli. E se la polveriera asiatica risulta troppo problematica, quale migliore occasione per cingere a braccia aperte l’Europa, con un occhio sempre a Est, s’intende.
Luca Orfanò
Al centro del nuovo mondo E’ un paese pazzesco, al centro della Storia da quando le civiltà esistono, e si fanno la guerra tra loro, e vengono sopraffatte le une dalle altre, inesorabilmente sostituite dalla storia. All’inizio fu il teatro della mitologia, delle storie più belle, di Pergamo, di Troia, e della guerra lunga dieci anni, combattuta per Elena, una donna bellissima. Poi venne la volta di Alessandro Magno, della verità della guerra, il condottiero macedone che si trascinò per l’intera Anatolia un esercito intero alla conquista dell’Asia, seminando morte e gloria tra Mileto, Alicarnasso e Isso. Di lì passò anche Cesare, giovane pontefice massimo esiliato dallo zio Silla nel regno di Nicomede, sullo stretto dei Dardanelli. Lì venne rapito dai pirati, che lo nascosero in una caverna sulle coste dell’Egeo, per poi chiedere il riscatto. Lui tornò tempo dopo, trovò il loro covo e li uccise tutti, crocifissi a testa in giù nei pressi di Marmaris. E’ anche il paese di Dio, si narra infatti che la Madonna fosse morta a Smirne. Intanto la Storia cavalca nei secoli, viaggia nei millenni, è la volta degli Ottomani. Un impero longevo, centinaia di anni a conquistare fette di mondo, da Vienna a Gerusalemme, dalla Grecia al Nord Africa. Prima contro le crociate, poi contro l’Europa intera, ci volle la prima guerra mondiale per porre fine all’impero dei sultani. Che tanto ha lasciato alla Turchia, la voglia di conquista, lo spirito di grandezza, la potenza, l’audacia, l’arroganza.
E’ la Turchia il paese di cui parliamo, al centro negli ultimi tempi degli squilibri mediorientali, abitudine della sua storia. Si tratta di una nazione giovane, formatasi nel Novecento con Ataturk, e arrivata ad essere una pedina preziosa negli equilibri della sua regione, e non solo. La Turchia è guidata da un Premier ( Erdogan) ed un ministro degli Esteri ( Davutoglu) che sono due fuoriclasse. Due figure che hanno portato il paese ad essere un prezioso alleato degli Stati Uniti, ma senza alcuna traccia di servilismo. La Turchia rappresenta un modello per tutte le neonate democrazie del Maghreb, che guardano al sistema di governo di Ankara ( uno stato di matrice islamica, ma democratico e indipendente) come al traguardo a cui ambire. E’ la Turchia l’unico attore in grado di bilanciare il potere di Israele nella regione, l’Iran vorrebbe esserlo, la Turchia già lo è. Un paese che ospita basi Nato a poche centinaia di chilometri dal confine con Iraq, Iran e Siria. Con quest’ultima la disputa è di pochi giorni fa: il governo di Ankara ha fermato un velivolo della Siryan Airlines, proveniente da Mosca e diretto a Damasco, sostenendo che stesse trasportando armi e apparecchiature informatiche destinate al regime di Bashar Al Assad. L’aereo è rimasto a terra nove ore, prima di ripartire con carico e passeggeri alla volta della Siria. Ciascun paese ha chiuso i propri spazi aerei all’altro. E’ evidente la prova di forza, lo scossone che si vuol dare, la miccia che si vuole accendere. I tank turchi grazie ad una delibera del Parlamento sono pronti, ad Erdogan pieni poteri. Sulla morente Siria incombe la smania di protagonismo della rampante Turchia.
 Un paese in costante crescita, non solo in termini di peso nella politica estera, ma anche economicamente, oltre che socialmente. Si tratta di una democrazia moderna, dove le donne sono emancipate, città come Istanbul sono un magnifico esempio di come gloriosa antichità e stimolante modernità si specchiano dai due lati del Bosforo, tra grattacieli e minareti. La Turkish Airlines, compagnia di bandiera, si sviluppa enormemente. Nel 2011 era la quarta compagnia aerea in Europa, traffico di passeggeri che si aggirava intorno ai 32,6 milioni. Tasso di occupazione salito al 72,6%. Bisogna considerare il grosso vantaggio politico di questo paese. La Turchia è a 3 ore di volo da cinquanta paesi. E’ in mezzo al mondo. E’ qui che Barack Obama, nel suo primo viaggio in Europa, venne a parlare ai giovani universitari. La Turchia si muove in fretta e bene. Fa sorridere pensare che tenta inutilmente di entrare nell’Unione Europea. I grandi strateghi di Bruxelles la snobbano, soprattutto i francesi, miopi davanti alla sua grandezza, incapaci di cogliere gli straordinari vantaggi che potrebbe comportare avere la Turchia come alleato, non come nemico. Proprio perché questo paese svolge in Medio Oriente quel ruolo di mediatore, di intermediario, che spetterebbe all’Europa, che invece si arrovella su se stessa, incapace di guardare verso la sponda sud del Mediterraneo.
La Turchia si sta conquistando il potere a morsi, e ci sta riuscendo magistralmente. Noi stiamo a guardare. Nonostante ciò gli scheletri nell’armadio ce li hanno tutti, le coscienze sporche non si lavano facilmente. Chiedetelo agli armeni.
Luca Orfanò
Come dietro un banco L’hanno pomposamente definito “un giorno storico per l’Unione”, il giorno in cui viene al mondo l’Esm, noto ai più come Fondo Salva Stati. Ideato da Mario Draghi qualche mese fa e varato dai ministri delle Finanze della zona euro oggi. Si tratta di un fondo privato, con sede in Lussemburgo, quello staterello in mezzo all’Europa, dove stanno la maggior parte dei fondi speculativi che non si trovano a Londra. L’Esm ha un suo capitale, al quale hanno contribuito in misura differente i 17 paesi dell’Eurozona. Con questo denaro emette obbligazioni ad un basso tasso di interesse, che hanno proprio oggi ricevuto dall’agenzia di rating Fitch la tripla A. Appena nato, nessuna obbligazione venduta, è già il primo della classe il nuovo Fondo. Quasi perfetto. Le condizioni di concessione dei prestiti da parte dell’Esm agli Stati che ne faranno richiesta non sono ancora molto chiare. Si tratta insomma di un giocattolo fantastico ( un Fondo che emette prestiti) sicuro e istruttivo per i bambini (bassi tassi di interesse, dietro ci sono gli Stati), ma per averlo i bimbi ( gli Stati finanziariamente in difficoltà) dovranno fare i compiti, tanti compiti, e bene. Certo i maestri (Bce e Commissione Ue) saranno più clementi nel correggerli di quanto lo siano stati con quella bimba ripetente ( Grecia), anche perché non ci sarà quell’arpia di insegnante, incubo di tutti i bambini con difficoltà di apprendimento ( Fmi).
Al di là dei paragoni il primo Paese a chiedere l’intervento di questo Fondo dovrebbe essere la Spagna, che però esita non essendo a conoscenza delle condizioni per ricevere il prestito. Madrid ha bisogno di circa 40 miliardi per riportare i conti in ordine, è impossibile alzare le tasse più di quanto non abbia già fatto. Inoltre il premier Rajoy oltre alle universalmente note proteste spagnole, deve risolvere la grana della Catalogna e della sua ritrovata volontà indipendentista.
Atene non se l’è mai passata meglio degli iberici, è così anche questa volta. La Grecia ha problemi diversi, più che con l’Europa tratta con creditori privati, grosse banche mangia bambini, queste sì. I soldi che la Grecia deve dare a Goldman Sachs e cugini li prende in parte dall’Europa e dal Fondo Monetario. Questi continueranno a concederglieli solo se il premier Samaras convincerà il Parlamento ad avviare presto nuove misure di austerity. In pratica la Grecia, come al solito, deve trovare soldi da dare alla Bce e al Fmi, affinchè questi glieli ridiano con qualche aggiunta per girarli a sua volta alle banche. Sempre la stessa storia. Il governo greco ora non chiede soldi, ma rinvii dei pagamenti, che vanno bene alla Bce, ma non ai tecnici del Fondo Monetario, che non mollano.
 Poi ci siamo noi. L’Italia che sta resuscitando con successo dal baratro in cui era finita, ma si porta dietro molte ombre. Una di queste, forse la più grossa con la corruzione, è la disoccupazione, che l’Istat ha stimato al 10,7 % . I tecnici della Banca Centrale Europea hanno corretto la cifra, portandola al 12,5%, poche unità di percentuali che si traducono però in migliaia di persone. Le stime di Francoforte sono peggiori perché includono anche gli scoraggiati. Quelli che il lavoro hanno smesso di cercarlo perché si sono arresi a non averlo, i vinti, il più grande problema del nostro Paese. Le questioni si accavallano, dall’Imu alla Chiesa che non si vede ancora, alle detrazioni fiscali per i lavoratori e le imprese. Ora nascono anche proposte di revisione della riforma delle pensioni, che sono corrette, ma alle quali il ministro Fornero si è opposto. Il Governo è contrario perché una tale modifica vorrebbe dire trovare i soldi, che da lì verrebbero a mancare, da un'altra parte. E si tratta di miliardi.
La buona volontà ce la mettono tutti, per chiunque. Però i conti devono sempre tornare, per forza. Qualcuno, tutti sanno chi, ma nessuno se lo ricorda, ha firmato per il 2013 a Bruxelles il pareggio di bilancio per l’Italia, messo in costituzione. Vuol dire che Monti deve presentarsi in Europa fra meno di un anno con delle carte ed una calcolatrice, dimostrando che lo Stato ha entrate pari alle uscite. Per tornare alla metafora scolastica, è come se due studenti avessero iniziato un progetto insieme, e presentandolo prenderanno un voto che sarà la media della valutazione che ciascuno per sè riceverà. Uno degli studente è un fanfarone, l’altro è serio. Il fanfarone molla il progetto a metà strada, lasciando tutto il carico sulle spalle del serio. Il fanfarone non ci perde nulla se la valutazione finale sarà insufficiente, lo studente serio ci perde la faccia e pure la sua pagella. Al fanfarone l’insegnante ha già dato 2, l’altro allievo dovrà prendere 10 facendo il doppio del lavoro nella metà del tempo. Non c’è bisogno che vi spieghi chi sono i due scolaretti.
Luca Orfanò
Breve ricostruzione di ciò che ha portato l’Iran e Israele ai ferri corti, con lo scomodo ruolo degli Stati Uniti. Le sanzioni sembrano non aver portato risultati: muovere guerra o accettare il rischio di proliferazione nucleare?
Questa storia che si dipana nelle arterie della politica internazionale inizia negli anni ’50. L’Iran era governato da Reza Pahlavi, filoamericano. Gli statunitensi non ebbero problemi ad appoggiare il programma per il nucleare civile proposto dallo Scià, che anzi ratificò nel 1970 il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP). Si iniziò a costruire un reattore a Bushehr, sulle coste del Golfo Persico. Al termine della Rivoluzione Iraniana (1979) le collaborazioni con i Paesi Occidentali furono immediatamente interrotte, e la persistenza del regime islamico fece sì che non vennero più riallacciate. Tuttavia la Russia di Eltsin offrì assistenza all’Iran, a partire dal 1990: nel 1995 si ricominciò a costruire il reattore I di Bushehr, mentre si estraeva uranio dalle miniere nei deserti intorno a Yazd, Iran centrale. Il metallo allo stato naturale è però innocuo, vista la bassa percentuale di Uranio 235, il responsabile dei processi di fissione. In un primo momento la Russia avrebbe dovuto vendere l’uranio arricchito, mentre successivamente l’Iran avrebbe restituito il combustibile esausto, a riprova degli scopi pacifici del suo programma nucleare. Nel 2002 un gruppo di dissidenti rivelò che nei pressi della città di Natanz veniva costruito un impianto segreto per l’arricchimento dell’uranio. La situazione si faceva problematica: il fatto che il materiale fosse prodotto in loco faceva temere che il regime potesse servirsene per produrre “bombe sporche (armi tradizionali che rilasciano scorie radioattive)” o, se fosse stato capace di svilupparne la tecnologia, per dotarsi di un arsenale nucleare. Varie ispezioni dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) non riuscirono a rintracciare resti di uranio arricchito nell’impianto di Natanz, ma questo non impedì, il 23 dicembre 2006, che il consiglio di sicurezza dell’ONU approvasse le prime sanzioni, rinforzate poi il 24 marzo 2007. In primo luogo veniva vietato l’export di armi iraniane, che però erano prevalentemente contrabbandate. Era anche proibito l’import, ma la scelta spettava ai singoli Stati. Altre sanzioni riducevano gli aiuti internazionali di cui l’Iran poteva beneficiare. Inutile sottolineare che le misure non sortiscono alcun effetto. Il governo di Ahmadinejad annuncia ufficialmente di aver installato 6000 centrifughe per la produzione di uranio arricchito a Natanz; nel 2009 entra in funzione a Isfahan un altro impianto. Quello che succede negli anni successivi è cronaca: alcuni scienziati nucleari iraniani vengono assassinati, sembra con un coinvolgimento del Mossad, i servizi segreti israeliani; un attacco informatico danneggia molti computer del programma nucleare, provocando una consistente perdita di dati. Anche qui è sussurrata la responsabilità di Israele, che più recentemente minaccia, anche se non in maniera aperta, un attacco preventivo, con il fine di distruggere le strutture nucleari iraniane.
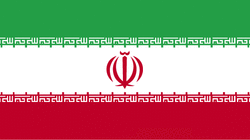
Barack Obama si è rivolto all’assemblea ONU del 25 settembre 2012, esprimendo una posizione abbastanza chiara. Gli Stati Uniti faranno “what we must” per impedire che l’Iran si doti di armi nucleari. "A nuclear-armed Iran is not a challenge that can be contained, it would threaten the elimination of Israel, the security of Gulf nations and the stability of the global economy". Se più o meno tutti i membri della comunità internazionale sono d’accordo a bloccare la presunta minaccia, pochi sembrano disposti a spingersi al di là delle sanzioni. In Iran la popolazione supporta il programma nucleare. Il tema comune è che, se tanti Stati nel mondo hanno un arsenale atomico, compresi India e Pakistan, perché non dovrebbe possederlo il loro Paese? La guerra fredda è durata più di quarant’anni, e nessuno ha mai premuto il pulsante rosso che avrebbe potuto portare alla distruzione dell’umanità: se non l’hanno fatto i fanatici comunisti, perché dovrebbero farlo gli estremisti ayatollah? Alireza Forghani, stratega di Khamenei, scrive sul suo blog (4 febbraio 2012):
“Iran is one of the countries that continued to be threatened by USA. […] The Islamic world should rise up and shout that "a nuclear bomb is our right to wake America and Israel up! Yes, having a nuclear weapon is a right. Right that if did not exist, Israel was destroyed forever thirty years ago and America had not right to flaunt in Iraq and Afghanistan. In order to prevent America to do whatever it wants, we should have the nuclear weapon.”
Forghani specifica che la linea politica non è ufficiale, ma la strategia è chiara: l’Iran si vuole servire della bomba atomica per acquisire un diverso peso specifico nelle relazioni geopolitiche mediorientali, ed è consapevole che usarla porterebbe alla sua immediata distruzione.
Gli Stati Uniti predicano stabilità. La situazione attuale non causa problemi a Israele, che può continuare le sue angherie nei confronti della Palestina e a chiudere un occhio sulla questione dei insediamenti in Cisgiordania. Una, una sola arma di distruzione di massa nelle mani dell’Iran cambierebbe questo scenario. Se devo esprimere un primo parere, concordo con Forghani. Dare all’Iran potere diplomatico potrebbe riequilibrare molte situazioni. Ci sono però molti elementi da considerare. Il primo è che anche l’Arabia Saudita, sunnita e alleata degli USA, vorrebbe la bomba, e questo scatenerebbe una nuova corsa agli armamenti. Il secondo è il rischio che piccoli gruppi di fanatici più estremisti del governo se ne possa impossessare, in particolare in caso di implosione del regime. Il terzo è proprio legato alle dinamiche interne: rinforzerebbe la dittatura, che comunque ultimamente non se la sta passando tanto male (la sensazione tra i giovani è di pessimismo, rinuncia e fuga all’estero). L’obiettivo dovrebbe essere quello di bloccare la proliferazione nucleare. L’utopia è che tutti gli Stati, Israele compreso, rinuncino al loro arsenale atomico. Non succederà. Quello che avverrà presto, invece, magari dopo le elezioni americane, sarà un attacco congiunto Israele-Usa alle installazioni nucleari iraniane, in piena violazione del diritto internazionale: ma tanto chi aprirà bocca? Toccherebbe, e fin da subito, alle opinioni pubbliche europee: se c’è una cosa di cui sono sicuro è che quella della violenza non è la via per risolvere il problema. Anche perché rinforzerebbe ancora di più il regime, e riaccenderebbe la fiamma del conflitto di civiltà.
Marco Pangallo
Avanti un altro “Al Lingotto tira una brutta aria”, niente di più falso. I dati disastrosi sulla vendita delle auto in Europa li conosciamo ( secondo l’associazione costruttori la media dei paesi Ue è di -10, -12% ) , quelli ancor più tragici della Fiat sono arcinoti, -18,2% . Marchionne di questi numeri fa il suo cavallo di battaglia, potremmo quasi chiamarla la sua scusante militante. La tempesta però tocca tutti, anche se in modo considerevolmente minore, si va dal -4 % della Germania al -11 % della Francia, passando per uno stabile +0,1 % del Regno Unito. Le auto nel Vecchio Continente si vendono meno che nelle altre parti del mondo, ma si vendono. Questi riportati sono dati rilevati su vendite dell’estate appena trascorsa, guardano al mercato dell’auto nel complesso. Analizzando invece in modo più particolare le singole aziende, ci si accorge che le vetture vengono acquistate, persino la Fiat in certi settori guadagna terreno, e vede confermare la Panda e la 500 come le vetture più vendute del segmento A. Ciononostante il problema rimane. In Italia si vendono poche auto, l’unica vettura della casa del Lingotto prodotta nella penisola è la Panda, a Pomigliano. Nel resto degli stabilimenti , da Mirafiori a Melfi, passando per Cassino, ad impegnare gli operai nelle poche ore rimaste di lavoro sono pezzi di auto, come per esempio Jeep a Torino, ma non esiste una linea completa. La mancanza di modelli è avvertita dai lavoratori in cassa integrazione, che vedono il futuro della fabbrica evaporare sempre più a ovest. Fiat è un’azienda che non punta su modelli da costruire in Italia, non scommette sull’innovazione, sulla competitività e su auto di nuova generazione, è tremendamente difficile nella crisi in cui ci troviamo, ma un manager questo deve fare, nient’altro. Questi i problemi dell’azienda al di qua dell’Atlantico, poi ci sono quelli del Paese. Tra questi ultimi rientrano i creduloni, quelli che sognavano Fabbrica Italia, i sindacati servili che hanno firmato un accordo che non era tale, ottenendo così la produzione di un singolo modello, in una sola fabbrica, e sentendosi dire che quell’accordo sarebbe stato esteso agli altri stabilimenti, in modo assai poco democratico, per poi vedere che l’accordo, sempre lui, non era la panacea di tutti i mali, e che dopo tanto furore per una firma gli operai rimanevano a casa, perché non c’erano macchine da fare. A questi creduloni si aggiunge il governo precedente, l’incompetenza industriale fatta persona, l’establishment della città di Torino, schierata senza se e senza ma dalla parte più grigia, quella senza diritti e senza progetti industriali, Fabbrica Italia.
E non è colpa di Marchionne se gli operai ora stanno a casa, o quantomeno lui è il responsabile minore, ad essere colpevole è la classe politica italiana, nazionale e locale, che ha permesso tutto ciò, nessun altro. Non solo Marchionne quindi, questo deve essere chiaro
 Il C.E.O. Fiat l’ha chiarito una volta per tutte sabato pomeriggio, a Palazzo Chigi, durante l’incontro col Presidente Monti: il Lingotto non ha soldi da investire in Italia al momento, non può permetterselo. Grazie lo stesso, aggiungiamo noi.
La questione è semplice. Fiat in Brasile, Serbia e Stati Uniti principalmente, va bene. E’ ben inserita nel mercato e gli utili che lì ottiene servono a sostentare quel poco che in Italia rimane da produrre. Marchionne ha successo laggiù perché questi paesi forniscono aiuti di Stato, che finanziano per esempio gli stabilimenti. Tali misure in Italia non sono più possibili, l’Unione Europea vieta gli aiuti di Stato alle aziende, menomale. Non è neanche più nel potere del Governo italiano porre dazi ai confini, quindi è impossibile un “protezionismo” a tutela delle auto Fiat, menomale. A decidere l’istituzione di dazi doganali è solo l’Unione Europea per i suoi confini esterni, menomale.
Quindi il Governo dal punto di vista del rilancio dell’azienda può fare ben poco, anzi nulla. Fiat in Italia fa quel che ritiene conveniente, chi grida ad una coscienza del Lingotto, secondo cui deve all’Italia molto e per questo dovrebbe restare con stabilimenti inefficienti, vuoti e senza operai, dà fiato ai polmoni. Non è colpa di Fiat che ha ricevuto finanziamenti pubblici a bizzeffe, è lo Stato che glieli ha dati. La politica tuttavia ha altri campi d’azione. In Europa esiste il libero mercato, e non c’è solo la Fiat nel mondo. Basterebbe aprire gli stabilimenti italiani ad altre case automobilistiche, dalla tedesca Volkswagen alle coreane, che già hanno manifestato interesse. E’ questa la nuova sfida, fare auto, non importa con chi. Ciò che è importante è che gli operai tornino a lavorare, chissenefrega se fanno la 500 o la Daihatsu Terios .
Luca Orfanò
Non esistono gli europei, ma almeno facciamo l'Europa! Chi vi scrive è un euroscettico. O meglio, una persona conscia di tutti i limiti dell’Unione Europea. Prima di partire per l’Erasmus ero anzi più convinto dell’idea degli Stati Uniti d’Europa, è dopo che ho iniziato ad avere molti dubbi. Mi è capitato più volte di trovare maggiori affinità con gente proveniente da Cile e Messico piuttosto che da Finlandia e Germania: tra la cultura latina e quella nordica permane un abisso, pur appartenendo entrambe alla cultura occidentale. Occidentale, non europea! Se Dante cercava l’odorosa pantera, cioè il volgare che doveva essere la futura lingua italiana, nessuno potrebbe trovare il toro che ingannò Europa, figlia di Agenore, concupita da Zeus. La cultura greco-romana è la base del mondo occidentale, non di quello europeo: non esiste una cultura europea in senso stretto. Uno dei momenti più belli del mio Erasmus è stato una sera, seduto sul balcone con un gruppo di amici, quando il freddo non aveva ancora allungato la sua lunga mano sulla Finlandia. C’erano delle casse e un computer, e a turno mettevamo una canzone che amavamo del nostro Paese. Io mi sono scritto molte di quelle canzoni, e le ho cercate e scaricate successivamente. Ora le sento occasionalmente, quando la funzione riproduzione casuale me le consegna. Sono in lingue che non conosco, ceco, polacco: leggere la traduzione in inglese non è la stessa cosa. Non avere una lingua comune è il limite, il primo insormontabile blocco ad una identità comune. Ognuno si ascolta le canzoni nella sua lingua, o quelle in inglese. Quando comunichiamo non possiamo esprimere appieno la nostra personalità in lingue diverse dalla nostra. Io non sono capace di inventarmi battute stupide in inglese! Gli italiani continueranno a rimanere italiani, gli spagnoli spagnoli, i polacchi polacchi. Un’altra cosa che viene citata spesso è il modello economico europeo. Il capitalismo responsabile, il welfare state. Sicuramente è uno dei motivi di orgoglio del nostro continente, ma non è una cosa unica al mondo. Prendete il Sud America, prendete l’India: non sono certo posti in cui le idee liberiste siano molto amate!
 Bene, ho terminato la pars destruens. Allora cosa ci unisce? In realtà è molto semplice, è la collocazione geografica. L’Europa è una quantità di Stati incastrati nel più piccolo continente della Terra, un calderone che ribolle di guerra e pace da migliaia di anni, una collezione di pietre d’ambra nelle quali rilucono ancora monumenti millenari. Ma le vestigia antiche ci sono anche da altre parti, la cosa che rende unica l’Europa nel mondo è proprio questa immensa diversità di culture ammassata in uno spazio minuscolo. Purtroppo nel mondo del XXI secolo questo significa soprattutto opportunità e problemi economici. Identifichiamo l’Europa con lo spread e la consideriamo come l’unica possibilità di controbilanciare il potere economico delle altre potenze. Un’amica finlandese mi disse: “Finland is sooo small, Russia is sooo big”. Vediamo dinamiche geopolitiche e ragioni economiche dove invece ci sono straordinarie opportunità di relazioni e di fusioni tra culture diverse. E allora i passi da fare sono due. Il primo è inevitabilmente quello di rinunciare a parti grosse della sovranità nazionale, a partire dalle politiche della difesa, come peraltro hanno già pensato le consumate élite burocratiche. Inoltre, la scelta alle Elezioni Europee del 2014 dovrà essere tra partiti europei, e non tra partiti nazionali; il Parlamento di Strasburgo dovrà avere potere vero, anche sui bilanci di tutti gli Stati dell’Eurozona. L’unica via d’uscita da questa crisi è che il Nord “perdoni” il Sud Europa, arrivando agli eurobond; quello che è successo però non si deve ripetere, e un’unione federale in ambito economico è l’unica rassicurazione per le opinioni pubbliche degli Stati che prestano denaro. Il secondo passo sarebbe di fare gli europei. Pensate a persone con la cordialità dei latini e con l’efficienza dei tedeschi: al confronto Batman e Spiderman sarebbero pivellini! Ma quest’ultimo sarà un processo centenario. Facciamo prima l’Europa. Anche se qualcuno si chiamerà fuori: ritornerà presto, resosi conto dell’irreversibilità del funzionamento il mondo.
Insomma, in una frase. Un’Europa federale è un’istituzione necessaria con fantastiche prospettive, che non ha ancora senso di esistere. Ma facciamola lo stesso!
Marco Pangallo
L'ultima carta di Beijing Avete mai giocato a Risiko? Io sì. Sul noto gioco da tavola che svela gli istinti coloniali di ognuno di noi le isole Senkaku non ci sono, anche perché le pedine ( i carri armati ) non ci starebbero. Facciamo luce sul mistero, perché è comprensibile che ci siano persone occupate a fare ben altro che controllare la cronistoria delle isole Senkaku. Si tratta di un piccolo arcipelago situato nel Pacifico, più precisamente nel Mar Cinese orientale. Quindi a sud del Giappone e a est della Cina. Isole controllate dal Giappone e rivendicate dalla Cina, la cui ultima mossa di alta strategia militare consiste nel pomposo invio di ben mille pescherecci a presidiare le isole disabitate. Dal canto loro i nipponici rivendicano da mesi la giurisdizione in nome dell’orgoglio del Sol Levante, celebre convitato di queste occasioni. Potremmo dire che il Giappone le possiede da sempre, che ci ha fatto poco o niente, sopra o intorno, e che pertanto potrebbe docilmente concederle ai turbolenti vicini, ma parleremmo a vuoto. In primo luogo perché i vicini non hanno mai preso in considerazione di chiederle gentilmente, ma se ne sono appropriati convinti di essere investiti di un diritto di proprietà quasi divino, secondariamente perché nonostante tutto non si tratta di sassolini in mezzo al mare, ma di pezzi di terra di grande valore geopolitico; da ultimo è assai improbabile trovare anche un solo giapponese disposto a concedere anche un solo chicco di riso ad un cinese. L’astio tra le due potenze asiatiche è antico, in epoca moderna risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando l’invasione giapponese della Manciuria portò le devastazioni del conflitto nelle case cinesi, e vi lasciò l’amara angoscia del teatro di guerra. E l’antipatia per l’invasore non si perdona mai, in Europa lo sappiamo bene. Per questo motivo quando si parla di Cina e Giappone si parla di intolleranza tra popoli, non paragonabile alle simpatiche schermaglie tra italiani e francesi, non riferibile all’incompatibilità tra greci e turchi. La storia è più vecchia, in gioco c’è il dominio di un continente, su cui il glorioso impero del Sol Levante ha dominato per quasi un secolo , e sul quale ora perde colpi come un vecchio samurai che non si arrende alle forze giovani.
 Questo è il momento della Cina, il momento di una nazione in crisi di identità, mai come ora. La crisi economica lambisce la Repubblica Popolare anche se di striscio, la sua marcia verso il progresso rallenta impercettibilmente. Il problema a Pechino è anche politico. La vecchia guardia terminerà la sua era fra qualche mese, i patriarchi del Partito Comunista sono sempre di meno. Con la fine del mandato di Hu Jintao, la nazione di Mao sbiadisce nella memoria come la foto del Grande Timoniere su piazza Tien An Men. L’avvento del nuovo Presidente Xi Jinping porterà una rivoluzione in ogni ambito del potere, in ogni provincia del Paese, e questi cambiamenti dopo gli ultimi sconvolgimenti interni saranno totali. La Cina è in ‘campagna elettorale’ , e in questi casi il vento di guerra funziona sempre, accende gli animi, porta la gente in piazza, fa issare le bandiere. Quale occasione migliore di una contesa che dura già da qualche tempo, contro un nemico vecchio e stanco, come è la nazione giapponese. Quella tra Pechino e Tokyo è una guerra di nervi. Le dispute sul Pacifico interessano anche Washington che infatti cerca di fare da paciere, anche se non è difficile capire in caso di conflitto da che parte si schiererebbe. Il Trattato di mutua alleanza tra Giappone e Stati Uniti implica che questi ultimi siano pronti a soccorrere il Giappone in caso di attacco di un paese straniero, questo prima o poi potrebbe essere il caso. Se Obama passerà, avrà anche questa ‘Pacifica’ grana.
Marco Polo racconta che alla corte di Kubilai Khan c’era un vecchio cieco, che veniva da una grande isola, non molto lontana dalle coste cinesi, dove si facevano spade formidabili, tanto da tagliare una foglia in due nel vento. Il vecchio gli raccontò che il Gran Khan possedeva l’intera Asia, ma tuttavia non era contento. Subì una sola grande sconfitta nella sua vita: tentarono di conquistare quell’isola, che avevano sentito afflitta da secoli di guerre civili. Ma quel paese ad ogni minaccia di invasione straniera era capace di riappacificarsi, di prendere le armi insieme, uniti nella lotta per la salvezza comune. Così le truppe di Kubilai Khan vennero rispedite a casa.
I cinesi non l’hanno mai mandata giù.
Luca Orfanò
Bravo Mario, bravo Ben Anche se Draghi sostiene che “c’è ancora qualcuno da convincere in Germania “, è stato compiuto un importante passo in avanti nel processo di risoluzione della crisi. Il 12 settembre, mentre il mondo guardava a Bengasi, la maggior parte delle cancellerie europee attendeva ansiosamente notizie da Karlsruhe, cittadina della Germania meridionale, nota poichè sede della Corte Costituzionale tedesca. Il sì della corte al Fondo Salva-Stati è arrivato, anche se condizionato, con grande piacere di Draghi, della Merkel e di tutti i cittadini europei dotati di buonsenso. Si tratta di un sì condizionato poiché la Corte di Karlsruhe ha posto il limite di 190 miliardi, come contributo massimo che la Germania potrà dare al Fondo Salva-Stati, senza l’intervento del Parlamento tedesco. E’ anche per questo che da Berlino la notizia è stata accolta con sollievo, in un anno di campagna elettorale sarebbe arduo presentarsi ogni volta alle Camere per chiedere soldi da destinare ai paesi deboli della zona euro.
Il Mes ( meccanismo europeo di stabilità), o Fondo Salva-Stati, è solo l’ultima di numerose misure che Mario Draghi e il suo staff hanno intrapreso dallo scorso novembre. Si tratta di un fondo al quale ciascun paese della zona euro contribuisce in modo differente, l’Italia ( 17% ) è il terzo contribuente dopo Germania e Francia. La Bce disporrà di questo fondo e deciderà a quali paesi e in che misura destinare gli aiuti, di cui potrebbe aver bisogno anche l’Italia. Le condizioni per ricevere questi aiuti sono assai diverse da quelle che caratterizzavano i prestiti della Trojka ( Bce, Fmi, Commissione Ue). Ciò significa che per fortuna non assisteremo più al pietoso spettacolo del Fondo monetario in cattedra e della Grecia dietro la lavagna. Questa è la risposta di Mario Draghi alla speculazione, l’obiettivo dell’Esm è, anche se indirettamente, porre un tetto agli spread, evitare quindi agli stati, come Italia e Spagna, di pagare tassi di interesse sul debito elevati in modo spropositato. Abbattere quindi costi che inevitabilmente ricadono sui cittadini, attraverso aumenti delle imposte o tagli della spesa pubblica. E’ quindi la risposta a chi punta a dividere l’Unione, partendo dallo spread e finendo chissà dove. Lo Esm nasce da una Banca Centrale che di centrale ha poco. Una Banca che non può limitare le decisioni al suo board, nonostante l’indipendenza riconosciutale costituzionalmente, ma che ha a che fare con interessi di parte, difesi strenuamente da opposizioni minoritarie, ma tuttavia con grande peso all’interno dell’Eurotower, una fra tutte, la Bundesbank e il suo governatore Weidmann. Tuttavia un voto democratico ha sancito la nascita del Fondo Salva-Stati, con buona pace di alcuni ottusi.
 Esiste invece una Banca Centrale indipendente oltreoceano, che decide autonomamente e senza condizionamenti esterni come agire nella politica monetaria del suo Paese. Questa banca è la Federal Reserve, e il suo governatore, Ben Bernanke, ha le mani molto più libere di Mario Draghi. La Banca Centrale Europea ha come unico obiettivo il controllo della stabilità dei prezzi, al quale adempie con una politica monetaria molto ‘tirata’, con in testa il mantra dell’inflazione; il mandato della Fed è invece molto più ampio, senza briglie. Uno dei suoi compiti principali è il sostegno dell’economia, della ripresa, quindi della crescita. Mentre a Francoforte guardano quindi all’inflazione, e solo a quella, a Washington pensano all’occupazione. Un tema, quest’ultimo, che da noi sembra scomparire nel mare di paroloni come fiscal compact. In America, oggi come quattro anni fa, la parola che incombe come un martello pneumatico nelle teste di tutti, dall’operaio disoccupato al banchiere centrale è job. La Fed punta a creare posti di lavoro, lo fa intervenendo direttamente nell’economia del Paese. Lo fa nel modo più semplice e ovvio, iniettando miliardi nel circuito economico a stelle e strisce. L’operazione ha un nome, quantitative easing. Si tratta dell’acquisto in maniera massiccia da parte della Banca di titoli di vario genere. Non solo titoli di stato, ma anche particolari bond ai quali sono legati gli andamenti dei tassi di interesse per i mutui delle case, tecnicamente detti mortgages bonds. E abbiamo imparato a capire che se questi bond vengono acquistati in grande quantità, quindi ne aumenta la domanda, gli interessi scendono. Traduzione: i mutui costano meno. E questa è solo una delle innumerevoli operazioni della Fed. Gli Stati Uniti si tormentano per una crescita del 2% circa, considerano insufficienti cifre che l’Europa intera si sogna di notte, e anche di giorno.
Bernanke quindi allinea la politica della Fed a quella dell’amministrazione Obama, che da questo punto di vista si avvantaggia. D’altro canto, se il banchiere centrale è dovuto venire in soccorso del Presidente, significa che le misure intraprese da quest’ultimo forse non hanno funzionato come dovevano. Anche in questa vicenda quindi, come in quella mediorientale, Barack Obama dovrà giocare bene le sue carte, le ultime, o quasi.
Luca Orfanò
09/12/2012  12 settembre 2012. Una giornata turbolenta, muore l’Ambasciatore americano in Libia, insieme ad altri funzionari e marines; il Maghreb intero è sconvolto da scontri di piazza e attacchi ai fragilissimi palazzi del potere neo costituito. Il casus belli è un film sconosciuto, opera di un regista ebreo israeliano altrettanto ignoto, che tratta di un Islam che conosce solo lui; e ne parla come fosse un cancro. Ma questo è appunto solo il casus belli. Da Tripoli al Cairo la tensione è alta, attacchi mirati minacciano le fondamenta già precarie di democrazie allo stato primitivo. Democrazie su cui, come è evidente, gli Usa perdono sempre di più la loro influenza. Ciò non significa che esse siano orientate verso estremismi di vario genere, ma bensì che la loro peculiarità diventa un forte nazionalismo interno, soprattutto in Egitto, paese ostile a qualsiasi voce esterna, compresa Al Qaeda. E’ infatti l’organizzazione terroristica che fa capo al medico egiziano, Ayman al-Zawahiri, ad aver rivendicato l’attentato in cui è rimasto vittima, tra gli altri, l’ambasciatore Stevens. Al Qaeda perde influenza su questi stati almeno tanto quanto Washington. Il diplomatico americano è stato un obiettivo chiaro, un profondo conoscitore del mondo arabo, un entusiasta dei movimenti rivoluzionari che avevano portato ad un cambio di regime. Nonostante perda influenza, Al Qaeda conserva in questi paesi diversi contatti, ramificazioni sottili, ma tuttavia insidiose, che fanno capo a certe frange della corrente salafita, ciò accade perlopiù in Egitto. Un assaggio di questo nuovo snobismo nazionalista, lo abbiamo avuto oggi in occasione di una dichiarazione del Presidente egiziano, Mohammed Morsi. In una conferenza congiunta con il Presidente della Commissione Ue Barroso, Morsi ha condannato, come era prevedibile, gli attacchi al consolato americano a Bengasi, ma ha ribadito un concetto chiaro: Maometto, il Profeta, è una linea rossa che non è consentito travalicare. Ciò non significa che il Presidente egiziano giustifichi l’attentato, che si schieri da una parte anziché dall’altra, tutt’altro. Morsi ribadisce una conditio sine qua non, di cui l’Occidente, diplomatico e non, dovrà tenere conto. Questa non è più l’epoca dei piedi in testa. Come a dire “ ora facciamo di testa nostra “.
 Sta cambiando tutto insomma, e molto in fretta. E non serve un attentato per capirlo. A fine agosto si è tenuta a Teheran la Conferenza dei Paesi non allineati, i famosi terzomondisti, la si potrebbe definire una delle tante scorie di guerra fredda, ma in Medio Oriente tutto è ancora “Guerra Fredda”. Nella capitale degli Ayatollah sono arrivati leaders e delegazioni da tutto il pianeta, e tra loro c’era anche Mohammed Morsi. Una presenza significativa dato che non accadeva da più di trent’anni che un Presidente egiziano mettesse piede in Iran. E a Teheran Morsi non ha usato mezzi termini, non si è schierato senza se e senza ma con la causa iraniana, ma nemmeno contro. Ha invece avuto il coraggio di condannare le violenze in Siria, definite oramai intollerabili.
Il caos è sotto gli occhi di tutti, è oggetto di inquietudine per tutti.
Non è più tempo di alleanze promiscue, di gentilezze diplomatiche, ognuno fa da sé e per sé. Lo stallo durerà, almeno per altri due mesi, Obama non può far molto, si va alle urne fra meno di due mesi. Mitt Romney lo attacca, anche piuttosto goffamente, ma il colpo da Bengasi il Presidente l’ha avvertito. Certo Obama non è Carter, certo la Libia di oggi non è l’Iran del ’79, ma di certo c’è solo questo.
Luca Orfanò
Il business non dorme mai / II Preso atto delle condizioni in cui viviamo, che ci fanno da contorno, non posso fare a meno di citare Kant, che nella sua immensa opera nota come Critica della ragion pura, scrive:
Ogni interesse della mia ragione (tanto quello speculativo quanto quello pratico) si concentra nelle tre domande seguenti:
1. Che cosa posso sapere?
2. Che cosa devo fare?
3. Che cosa ho diritto di sperare?
Tralascio il punto 1, perché credo che al fine di proseguire in modo lineare con l’intervento, i punti 2 e 3 siano più importanti. Chiaramente Kant, attraverso queste tre domande costruisce un pensiero filosofico molto complesso che non è mia intenzione esplorare; credo siano importanti proprio le domande in sé, e credo sia ancor più importante darsi delle risposte.
Cosa possiamo fare e cosa abbiamo diritto di sperare, dunque, in un sistema come il nostro, dove il Business non è più il Nostro Business, dove lo Stato non è più il Nostro Stato, dove il nostro scopo più intimo, ovvero la fantomatica ricerca della felicità, non trova più spazio in tutto ciò che ci circonda?
Darsi una risposta è estremamente difficile; io credo che essa stia, ancora una volta, in un’attività; ovvero nell’atto stesso di porsi la domanda e cercare di rispondere, ecco che stiamo effettivamente rispondendo. Riconoscendo il paradosso del sistema, constatando quanto sia difficile collegare l’origine del lavoro e dell’economia con quello che oggi è effettivamente il lavoro e l’economia, già stiamo facendo un passo avanti.
Sarò sincera, so quanto conti lottare per cambiare il mondo, ma so anche quanto profondamente possa apparire inutile al giorno d’oggi, dove il senso stesso di cosa dovrebbe essere il mondo è smarrito,(sono pronta ad accogliere critiche di chiunque, a differenza mia, non pecchi di post-modernismo) per cui credo che più importante sia il cercare di rivoluzionare dapprima il nostro sguardo verso il mondo, il nostro modo di vederlo, più che, almeno per il momento, il mondo stesso.
Dobbiamo inserirci nel sistema, non possiamo ritirarci, ma possiamo, tutt’al più, farlo consapevolmente. Possiamo scendere al compromesso di diventare merce di scambio, ma dobbiamo farlo tornando a casa, e guardandoci allo specchio, avere la forza di dire IO NON SONO QUESTO. Io sono il sorriso che si apre sul mio volto, sono le lacrime che verso, l’amore che provo, i libri che leggo, i sogni che ho. Dobbiamo avere la forza di non far perire l’uomo aristotelico assetato di verità, conoscenza, giustizia e diletto che è in noi, dobbiamo opporre al Business, il nostro piccolo business, che non stabilisce prezzi, che non c’inganna, che dorme con noi, con noi si sveglia, con noi assegna i giusti valori alle cose.
Emile H. Gauvreay scrive “Abbiamo costruito un sistema che ci persuade a spendere il denaro che non abbiamo in cose che non necessitiamo per crearne impressioni che non dureranno su persone che non ci interessano”: questa è un’amara verità. Possiamo però rispondere a questo con il prenderne consapevolezza e distaccarcene, in attesa di trovare la forza, un giorno, se mai sarà possibile, di costruire un sistema alternativo, che meglio si sposi con l’altra faccia della medaglia, con l’atto di libertà, con l’Essere in rapporto al Divenire, che ci permetta di ritrovare noi stessi, di ricostruirci un’immagine, un ruolo nel tutto, un ruolo che la società di massa ha cancellato.
Molti sono stati i filosofi ad occuparsi di questo tema, soprattutto da ‘700 in poi, ma per pietà del lettore non vi farò ricorso; concludo soltanto dicendo che, probabilmente, dall’Economia nella sua origine, o οἱκονομία (Tesi) ora stiamo ancora sguazzando nel Business (Antitesi), in attesa di un terzo elemento, che possa conciliare e superare i due opposti (Sintesi).
Sì, dopotutto spero che Hegel abbia ragione, che dopo la crisi si ritorni in-sé e per-sé, arricchiti e più consapevoli.
Ma soprattutto, felici.
Elisabetta Ceroni
|